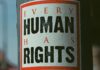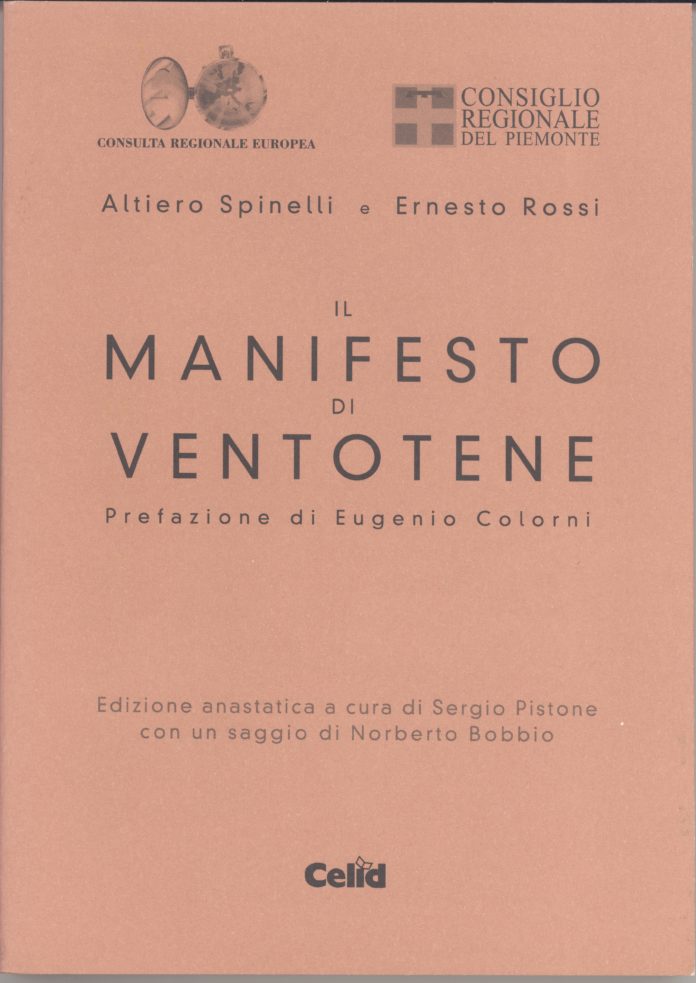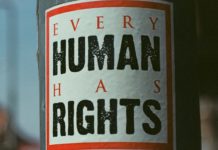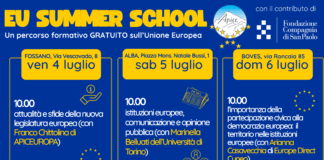La seconda parte del titolo di questa nota è rubato ad un libro famoso dello scrittore argentino Osvaldo Soriano che racconta le tristi vicende del declino di Stan Laurel il comico che, in coppia con Ollio nel secolo scorso, aveva tanto rallegrato i suoi numerosi spettatori. Una storia che, con quelle tre parole, sembra alludere alla straordinaria avventura del sogno europeo iniziata nel secolo scorso e che, per oltre settant’anni, ha dato serenità ai popoli europei, durante la lunga tregua da guerre vissuta dentro lo spazio protetto della Comunità europea, ma che nell’Unione di oggi vive giorni difficili.
Quel sogno, nato dall’incubo della tragica Seconda guerra mondiale sulla scia di secoli di conflitti che avevano dilaniato l’Europa, aveva avuto molti padri: tra i più noti, in Francia Robert Schuman e Jean Monnet, in Italia Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, autori del “Manifesto di Ventotene” e, a Cuneo, Duccio Galimberti e Antonino Repaci, autori di un “Progetto di Costituzione confederale europea e interna”.
Oggi quel progetto europeo, variamente declinato da quei Padri fondatori, sembra non avere più eredi, col rischio di ritrovarsi “triste, solitario e alla fine”, se nuovi “rifondatori” non si fanno avanti a contrastare i molti “affondatori” oggi all’opera.
Per tanti cittadini d’Europa il progetto di riunificare nella pace il continente sembra essere finito tra le “passioni tristi” di questa nostra epoca, incapace di uscire dalla passività indotta dalle molte sofferenze della vita contemporanea, senza riuscire a trasformarle in slanci verso un futuro più temuto che sperato, con le guerre ai nostri confini e la paura nucleare.
Questa passione triste trova qualche spiegazione nella prospettiva di un destino “solitario” di questo inedito progetto europeo, nato per ricostruire un continente dalle macerie, in una stagione oggi della storia nella quale sono in tanti a provocare nuove macerie, a dividere invece che ad unire, a logorare le sedi del confronto multilaterale e ad alimentare conflitti di tutti contro tutti.
Da chiedersi, a questo punto, se questo straordinario progetto di pace stia lentamente affondando nella sua fase “finale”, con il ritorno delle frontiere interne, il nostalgico sventolio delle bandiere nazionali, una nuova incontrollata corsa al riarmo di ciascuno per sé, abbandonando le sedi del confronto e del dialogo, lasciandosi alle spalle il presidio del diritto internazionale, calpestato ormai senza esitazione da belligeranti di diverso colore, compreso da quelli che si vantano di vivere in democrazia.
A questo punto resta, fragile, la speranza in un futuro “dopoguerra”, un’occasione che ha consentito a più riprese all’Europa di ricostruirsi su nuove fondamenta, di riconoscere i propri errori e le sue numerose omissioni e ritrovare nella sua cultura plurale, da quella razionale della Grecia a quella solidale della religiosità cristiana fino a quella orgogliosamente rivendicativa dell’umanesimo e dell’illuminismo, riprendendo con nuovo slancio e tenace pazienza a tessere trame di pace e convivenza civile.
Ciò sarà possibile se dall’esperienza preziosa dell’Unione disunita degli Stati nazionali di oggi nascerà, con chi ci sta, una nuova “Comunità europea”, dove siano protagoniste le persone di ogni colore e nazionalità, valori fondanti la giustizia e la solidarietà, per affrontare sfide di straordinarie dimensioni: dalla salvaguardia del pianeta alla riduzione delle disuguaglianze, dalla cura per un continente che invecchia fino all’accoglienza di migranti che lo ringiovaniranno e daranno colore a questa pallida Europa che rischia di appassire, minacciata di trasformarsi in un soggetto “triste, solitario y final”.