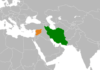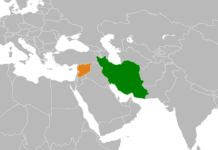Le turbolenze che stanno modificando il paesaggio politico della sponda meridionale del Mediterraneo, e che non sono certo giunte ad un esito finale, interpellano l’Europa e l’Italia in modo particolare.
E non solo per la vicinanza geografica e per il grave problema degli sbarchi che da questa derivano, molto di più per i valori di libertà e democrazia che hanno alimentato proteste e rivolte e per l’assetto futuro di una regione del mondo dove covano conflitti, come quello israelo-palestinese, e pericolose tensioni internazionali, come nel caso dell’Iran, e dove si intrecciano importanti interessi economici, primo fra tutti quello delle forniture energetiche.
In una situazione del genere sarebbe stato essenziale, per l’Unione Europea e per l’Italia, poter contare su una politica estera consolidata e coerente, in grado di gestire un presente difficile e progettare un futuro problematico a fronte di un mondo che sta cambiano rapidamente, con gli Stati Uniti in difficoltà a proseguire nel loro ruolo tradizionale di «gendarmi» e la Cina che si affaccia prepotentemente sulla scena mondiale, con una presenza sempre più massiccia proprio in Africa e una fame crescente di materie prime e di risorse energetiche.
Purtroppo a questo appuntamento siamo giunti impreparati.
Impreparata lo è l’Unione Europea che da anni procede con esasperante lentezza verso un coordinamento delle politiche estere nazionali dei suoi Stati membri e che nemmeno con il Trattato di Lisbona è riuscita a realizzare progressi sostanziali.
Ne sono una prova, tra l’altro, la pallida figura della baronessa Ashton, designata a rappresentare una politica estera europea inesistente e l’ottusa tenacia con la quale Stati membri, nostalgici di un passato che non c’è più come nel caso del Regno Unito e della Francia, si ostinano a credere di poter difendere da soli i propri interessi nazionali senza delegare questo compito ad un’autorità federale europea.
Non meglio preparata giunge l’Italia all’appuntamento delle turbolenze mediterranee come è sotto gli occhi di tutti a proposito in particolare della Libia e come fu già chiaro nelle esitazioni nel caso dell’Egitto con un sostegno fuori tempo massimo di Berlusconi a Mubarak.
Nel caso dell’Italia, all’assenza di una politica estera coordinata e preveggente, si aggiunge la gestione molto personalistica dell’attuale presidente del Consiglio italiano, di cui si ricorda nel mondo la politica delle «pacche sulle spalle», dall’amico Putin ad un personaggio ancora più impresentabile come il dittatore bielorusso Lukashenko per finire con le comparsate in Libia e in Italia con Gheddafi.
Non stupisce quindi che in un’Europa, pur non esente da responsabilità , ritardi e omissioni, l’Italia appaia come un partner tra l’inaffidabile e il superficiale, come ci raccontano ancora gli ultimi documenti di Wikileaks.
Così il conto all’Italia viene presentato quando da questa viene una giusta richiesta di solidarietà a fronte di inquietanti flussi migratori, con un’Europa un po’ meschina che si nasconde dietro la lettera dei Trattati, approfittando dell’alibi robusto che le offre un partner giudicato poco serio.
Ci sarà molto da fare, nei mesi e anni che verranno, perchà© l’Europa si decida finalmente a parlare ad una voce sola nel mondo e perchà© l’Italia metta mano ad una politica estera che, almeno in quello che fu il «mare nostrum», il Mediterraneo, ritrovi serietà e comportamenti rispettosi delle istituzioni, facendo dimenticare al più presto la politica delle «amicizie personali» e delle barzellette.
Anche se non intervenire per fermare i massacri in Libia per «non disturbare» l’amico Gheddafi non è propriamente una barzelletta.