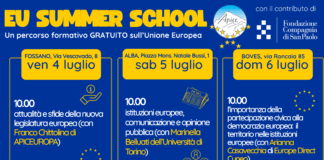Da più fonti europee ci sono arrivate nei giorni scorsi informazioni che convergono nel disegnare un’Europa caratterizzata da grandi differenze e un’Italia che arranca in affanno nelle classifiche dei 27 Paesi dell’Unione Europea. Numeri e dati sono stati sfornati dalla Banca centrale europea (BCE), dalla Commissione europea e da Eurostat, l’autorevole Ufficio statistico dell’UE.
La fotografia che si ricava dell’Europa è quella di una somma di Paesi che divaricano fra di loro su quasi tutto, alla faccia della loro dichiarata adesione al processo di integrazione sottoscritto con i Trattati. Vale per la situazione dei conti pubblici, con debiti doppi tra un Paese e l’altro, per i tassi di crescita e per quelli della disoccupazione (per la BCE a livelli senza precedenti e destinata a salire ancora), per la spesa sociale e per gli investimenti nell’istruzione e nella ricerca.
Su questi ultimi dati può essere utile soffermarsi a riflettere.
I Paesi UE destinano mediamente alla spesa pubblica nazionale metà del loro Prodotto interno lordo (PIL). Per memoria, al bilancio europeo è destinato appena l’1% del PIL UE: un differenziale che la dice lunga sul reale tasso di solidarietà europea.
Non meno interessante scoprire la ripartizione della spesa sociale nell’UE: si va da oltre il 25% in Danimarca (quasi 11mila euro pro capite) a meno dell’11% in Slovacchia con l’Italia appena sopra il 20%, pari a poco più di 5mila euro pro capite. E anche per la sanità non siamo quegli spreconi che si vorrebbe far credere: spendiamo sensibilmente meno di Olanda, Danimarca, Francia e Gran Bretagna.
Sul versante particolarmente sensibile – e decisivo per il nostro futuro – degli investimenti nella cultura, istruzione e ricerca i dati europei dovrebbero dare qualche brivido a chi sarà chiamato a governare l’Italia, speriamo presto.
Gli investimenti nella cultura sono lontani da quello che sarebbe appena normale per un Paese che ha avuto in dote uno dei più grandi patrimoni culturali del mondo, ormai così trascurato da attrarre sempre meno turismo e, quello che è anche peggio, da non alimentare la crescita culturale delle nuove generazioni.
Non va meglio sul fronte caldo dell’istruzione, dove l’Italia tocca il fondo, sempre sperando che non prosegua fino a scavarsi la propria tomba. Per capirlo basta uno sguardo ai numeri dei giovani, nella fascia 30-34 anni, che hanno conseguito qualifiche nell’istruzione superiore, dove la media UE è salita al 36% contro il 28% del 2005: l’Italia galleggia negli ultimi posti con un misero 21,7%, dietro le percentuali doppie di Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Lituania e appena a pari merito con Romania e Malta. In compenso da noi crescono gli abbandoni scolastici, con il peggiore risultato di tutta l’UE.
Per quelli, sempre meno, che in Italia hanno un lavoro, è andata un po’ meglio per quanto riguarda i costi della manodopera, saliti fra il 2008 e il 2012 come nella media europea, poco al di sotto del 9%.
È probabile che la ragione di questo buon risultato sia da attribuirsi in gran parte alla capacità di rivendicazione dei sindacati. Negli stessi giorni in cui piovevano i dati appena citati, la Commissione europea rendeva pubblico un rapporto sulle relazioni industriali in Europa dal quale risulta l’ottima posizione dell’Italia nelle classifiche del “pluralismo” sindacale: sulle 256 sigle sindacali presenti nei 27 Paesi UE ben 56 sono nostre, nella sanità su 172 sono italiane 16. Non è proibito pensare che forse con meno sigle potrebbero migliorare le relazioni industriali nel nostro Paese.
Viene il sospetto che tutti questi dati abbiano a che fare con le recenti raccomandazioni all’Italia perché recuperi produttività, decentri la contrattazione salariale e potenzi il settore educativo.
Ulteriori raccomandazioni che vanno ad aggiungersi al severo promemoria europeo per il nostro futuro governo al quale non mancherà il lavoro.