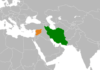Calais è una città del nord della Francia, famosa per essere la sede dell’imbocco del tunnel della Manica.
Ma oltre a questo particolare economico questa città è tristemente nota per essere la città che ospita uno dei più grandi campi profughi d’Europa, quello che viene tristemente definito “the jungle”, nome che è ormai talmente noto da essere entrato anche nel linguaggio degli occupanti del campo.
Il campo di Calais non è come tutti gli altri: si tratta di più di 9000 tra uomini, donne e bambini che vivono su tende costruite su una ex discarica. C’è chi cerca di andare in Inghilterra, ma c’è anche chi sta aspettando il riconoscimento del diritto di asilo in Francia. E poi c’è chi semplicemente si rifugia a Calais perché il Paese di prima accoglienza che secondo gli accordi di Dublino dovrebbe occuparsi della sua accoglienza, gli ha intimato di dover tornare nel proprio paese di origine, da dove lui però scappa.
Si tratta di una ex discarica che diventa un rifugio. L’accordo di Dublino, che obbliga i richiedenti asilo di risiedere nello stato di riconoscimento è anche questo. L’Europa è anche questo.
Il campo di Calais non è un campo riconosciuto, pertanto è gestito solamente da associazioni che cercano di fare il loro meglio con quello che hanno. E fanno un lavoro eccezionale, attento al rispetto della dignità dell’individuo e alla sua privacy, lavorano duramente per rimediare a questo gap ingiusto e ingiustificabile, che si è creato tra due parti del mondo.
Non si tratta di un campo nato recentemente, in quanto nasce con la guerra nei Balcani, più di 20 anni fa. Da quella data in poi non ha mai smesso di esistere, ingrandendosi notevolmente con la guerra in Iraq. La ragione dell’esistenza di questo campo è un accordo tra un soggetto privato e lo stato, cioè tra la società Eurotunnel che ha in gestione per 99 anni il passaggio tra Inghilterra e Francia. Nel momento della stipula del contratto, infatti, la Francia ha accordato di assumersi la responsabilità del controllo dei passaporti dei passeggeri verso la Manica, accollandosi inconsapevolmente anche l’onere della gestione dei migranti di oggi.
Quello che disarma nella “giungla” è la totale scomparsa dell’individuo, e di tutto ciò che rende una persona unica e padrona della propria esistenza. Lì dentro chiunque non è più nulla se non altro che un “profugo”. Abbiamo incontrato gente di ogni tipo, ma nel momento in cui si scappa abbandonando tutto non si è più null’altro se non uomini che vestono vestiti che non hanno scelto, che si cibano grazie alle donazioni delle associazioni caritatevoli e che aspettano una speranza per un tempo indefinito. Tutta la vita passata viene cancellata una volta varcato il confine europeo, non importa cosa hai studiato, cosa hai fatto, che mestiere facevi. Si possono conoscere professori, architetti, ex funzionari delle Nazioni Unite e anche bambini soldato ormai cresciuti.
Tutto scompare, si è solo più gente in attesa, una vita in stand-by passata a combattere con chi non ci vuole, come la maggior parte della popolazione stessa di Calais, che spesso osteggia anche gli stessi volontari.
Alcuni richiedenti asilo non sono alla loro prima esperienza di questo tipo. Molte persone dall’Afghanistan sono già state in Europa dove hanno vissuto per anni, fino al momento in cui hanno ricevuto un mandato di espulsione perché il loro paese di origine è stato riconsiderato un paese sicuro e in pace. E dopo essere tornate e aver schivato alcune pallottole, si sono rimesse in viaggio, a piedi, sfidando di nuovo la morte e pronte a riprovare. E ora vivono delle vite interrotte, frutto della scelta di rimettere tutto quello che si ha in gioco per cercare di avere una vita degna di essere chiamata tale.
L’ultimo giorno al campo veniamo evacuati, si sospetta una rissa tra la comunità afgana e quella sudanese. Nel campo circola la fotografia di un ragazzo sudanese ucciso nella notte in seguito ad una lotta tra le due comunità per la spartizione di piccoli territori del campo, e per l’assalto notturno ai camion che vanno verso l’Inghilterra. Una paradossale lotta per un fazzoletto di terreno (o meglio, una ex discarica), una lotta per un posto in prima fila nel viaggio verso la morte. E noi di nuovo scappiamo nel nostro orto felice, lasciando che la disperazione dilaghi ma che non ci coinvolga.
Il giorno dopo cerco notizie sui giornali di questa situazione, ma non ne trovo se non qualche notizia in giornali francesi. La vita di qualche straniero vale troppo poco per essere ricordata.
L’esperienza a Calais regala emozioni contrastanti, un senso di impotenza e di colpa, la consapevolezza di quanto è piccolo l’essere umano europeo, incapace di ascoltare le storie di questi esseri umani (e di considerarli tali), occupato invece a denigrare le loro scelte erigendosi a giudice indiscusso e detentore di diritti acquisiti, nemmeno lui sa da chi e come. Ma rimane anche la voglia di tornare alla vita reale, col desiderio di poter parlare alle persone che sembrano aver perso l’umanità e aiutarle a capire cosa non stanno ascoltando e vedendo, facendosi cittadini dell’Europa che include e non di quella che emargina e dimentica una parte dell’umanità che supplicando chiede aiuto.
Rimane la felice consapevolezza di aver vissuto giorni di grande ricchezza e di aver visto con i propri occhi che esistono tanti individui, di ogni età, di ogni stato, con capacità differenti e variegate, che decidono di donare il proprio tempo e le proprie energie per raggiungere insieme il mondo che vogliamo. E questo dà speranza. Calais non è soltanto un campo profughi, Calais è un orto di consapevolezza e di energia. La Jungle non spaventa, la jungle aspetta gente che voglia far parte del cambiamento.
A cura di Francesca Cavallera